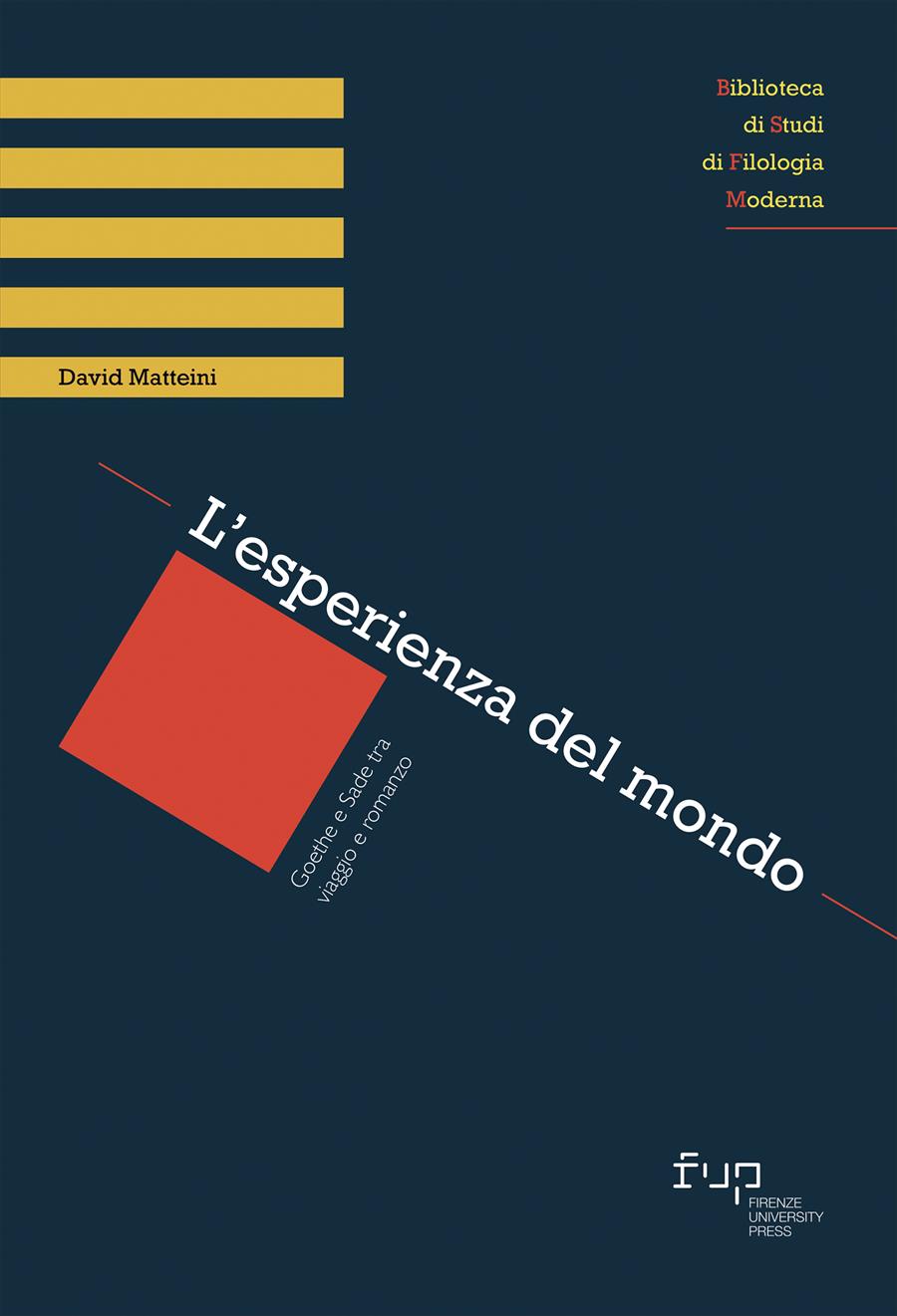
Altre news
L’esperienza del mondo
Goethe e Sade tra viaggio e romanzo
07/02/2025
Gli anni 1738 e 1748 segnano un momento di svolta nella storia delle idee. Nell’arco di un solo decennio rividero la luce le rovine delle antiche città di Ercolano e Pompei, per quasi due millenni seppellite sotto la coltre di cenere, fango e detriti generata dalla tragica eruzione del Vesuvio del 79 d.C. I lavori di scavo, condotti per volere di Carlo III Borbone e del suo erede Ferdinando IV, si sarebbero protratti per i due secoli successivi, ma già a partire dalla seconda metà del Settecento l’eco dei ritrovamenti fu vastissima su tutto il continente, portando con sé importanti conseguenze di ordine estetico e, non ultimo, politico e filosofico. Al di là dell’indiscusso valore archeologico, infatti, la straordinaria scoperta contribuì a un deciso mutamento della funzione culturale che aveva da sempre rivestito l’immagine dell’Italia. Considerata per secoli come il luogo elettivo per l’iniziazione della gioventù aristocratica europea alla vita mondana e di corte, l’Italia iniziò a presentarsi al viaggiatore del Settecento nell’inedita veste di territorio franco dove poter condividere con altri pensatori e artisti provenienti da tutta Europa le proprie risorse intellettuali secondo i principi dell’emergente ideale cosmopolita e della teoresi storico-artistica del Neoclassicismo di Johann Joachim Winckelmann, autore che, come è noto, si trasferì definitivamente a Roma nel 1755. Autentico paesaggio della memoria nel quale si viaggiava per ritrovarvi le suggestioni recepite nei libri, nei dipinti, nei resoconti dei grandi artisti del passato, l’Italia divenne ben presto la meta privilegiata per assimilare i valori di una civiltà rimasta per secoli nell’oblio. La riscoperta dell’eredità classica della civiltà magno-greca si manifestò su larga scala con il fenomeno odeporico del Grand Tour, vero e proprio modello conoscitivo-esperienziale che, seguendo una lunga tradizione risalente all’Umanesimo e al primo Rinascimento, ha rappresentato una delle più solide forme simboliche della civiltà letteraria europea del secondo Settecento, pendant di quella credenza tutta illuministica secondo la quale al di sotto della varietà dei costumi e delle leggi dei popoli sarebbe rintracciabile l’impianto uniforme di una morale naturale e dunque universale. Se l’esperienza gnoseologica offerta dal rinnovamento settecentesco del tradizionale tour italiano ha insomma trovato numerose corrispondenze con le f ilosofie del periodo, la categoria che più delle altre si è costituita come il fondamento di questo nuovo modo di viaggiare è da individuare senza dubbio in quella di “formazione”, la Bildung, concetto che nel Settecento inizia ad acquisire un’indiscussa rilevanza filosofica, e che, nella sua esplicitazione odeporica, sembra trovare le sue basi esattamente nella contemplazione dell’alterità culturale e, al tempo stesso, nella ricerca di universali umani e morali. Nel valore formativo acquisito dal Grand Tour si ritrova così un afflato umanistico che, partendo dall’individuo, abbraccia l’intero, per ritornare infine verso la consapevole integrità del soggetto all’interno della società umana. Il legame tra la formazione individuale e il viaggio che si consolida nella seconda metà del Settecento stabilisce così una nuova visione, estetizzante e allo stesso tempo politica, dell’esperienza del mondo. Oltre che nel perentorio rifiuto delle mode aristocratiche del barocco e del rococò primo settecentesche, il Neoclassicismo e la componente paneuropea del Grand Tour hanno costituito la cassa di risonanza ideologica di quelle frange liberal-progressiste che avrebbero portato entro poco alle grandi rivoluzioni di fine secolo e alla nascita di un nuovo modo di intendere la fenomenologia artistica e letteraria. A partire da questi motivi, il presente studio vuole approfondire le prospettive interpretative di due generi narrativi fondamentali per la comprensione della cultura europea del secondo Settecento: il viaggio in Italia – o meglio, il resoconto del viaggio in Italia – e il romanzo di formazione, due forme letterarie che, seppur differenti, ritrovano il loro punto comune in quel legame tra esperienza individuale, mondo sociale e mondo naturale che si instaura proprio nell’esperienza del viaggio. Per valutare l’eterogeneità degli esiti nel panorama della cultura a cavallo tra XVIII e XIX secolo, prenderemo in esame la Italienische Reise (effettuato tra il 1786 e il 1788, ma il cui resoconto è stato pubblicato in due volumi solo nel 1816 e il 1817) e i Wilhelm Meisters Lehrjahre (1796) di Goethe, testi già largamente conosciuti e discussi dalla critica, e il Voyage d’Italie (effettuato tra il 1775 e il 1776, ma il cui resoconto non è mai stato pubblicato dall’autore) e l’Histoire de Juliette ou les Prospérités du vice (1800, ma stampato con la data falsa del 1797) di Donatien-Alphonse-François de Sade, opere, quest’ultime, che non hanno mai trovato veramente spazio in uno studio teorico-comparativo di ampio respiro.